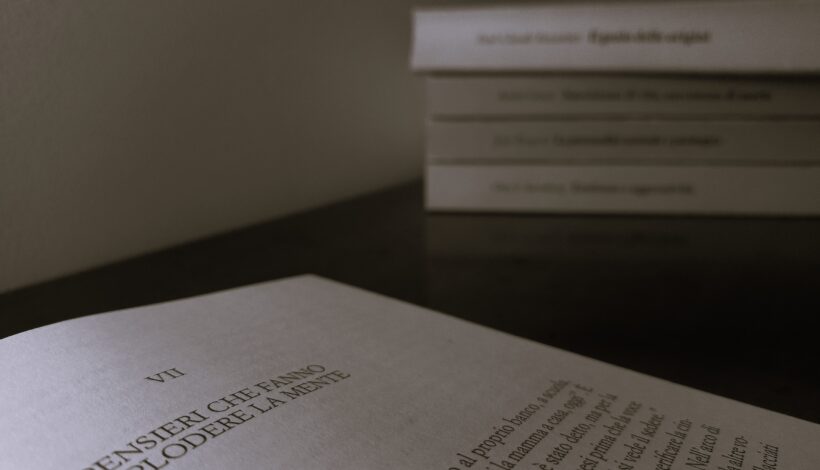Uno degli aspetti più complessi del lutto è quello di stabilire la differenza tra lutto normale e patologico; anche la scelta dei termini utilizzati per definirli ha suscitato, infatti, controversie.
Alcuni autori restringono il termine mourning (lutto) al lutto patologico mentre il termine grief (dolore) alla reazione normale; altri autori utilizzano invece, la denominazione mourning esclusivamente ai processi con un’evoluzione positiva.
Bowlby utilizza il termine grief per indicare le condizioni soggettive che emergono successivamente alla perdita ed accompagnano il lutto, mentre, il termine mourning, viene utilizzato dall’autore per indicare tutti i processi psicologici originati dalla perdita, sia consci che inconsci (Bowlby J., 1983; Grinberg L., 1971).
La tesi di Bowlby stabilisce un rapporto tra le reazioni patologiche osservate in pazienti adulti e le reazioni alla perdita osservabili nell’infanzia creando un nesso tra una condizione psichiatrica rilevabile in età adulta e l’esperienza riscontrata durante l’infanzia.
Bowlby ritiene che i processi di lutto verificatesi nei primi anni di vita tendono ad avere un’evoluzione patologica e rendono il soggetto più predisposto, rispetto ad altri, ad avere reazioni anomale difronte a perdite future.
L’autore sostiene che le perdite possono essere dannose e potenzialmente patogene sia se si verificano nei primi cinque anni di vita del bambino, sia in età più avanzata.
Bowlby osserva il comportamento di bambini di circa due e tre anni di età, i quali sono stati allontanati momentaneamente dalle cure materne e dall’ambiente familiare ed allevati da persone esterne. In seguito, attenziona l’atteggiamento del bambino al suo rientro in casa ed individua tre fasi diverse in base al suo comportamento nei confronti della madre: fase della disperazione, fase della protesta e fase del distacco.
La fase della protesta può durare diversi giorni ed è caratterizzata dai pianti e dalla collera del bambino che invoca il ritorno della madre e la rimprovera di averlo abbandonato. Successivamente appare più calmo ma profondamente preoccupato per l’assenza della madre; tuttavia, sembra ancora fiducioso nel suo ritorno.
La fase della disperazione insorge dal momento in cui la speranza nel ritorno della madre viene meno. Queste due fasi spesso si alternano e portano alla terza fase, quella del distacco, in cui il bambino sembra essersi dimenticato della madre ed al suo ritorno reagisce con indifferenza e disinteresse.
La durata del distacco del bambino appare correlata con la durata del periodo di allontanamento.
Bowlby sostiene che il distacco è il risultato di un processo difensivo regolare nel lutto in qualsiasi età e che tali reazioni caratterizzano tutte le forme del lutto.
La collera può essere considerata come la prima reazione alla perdita della persona amata e parte integrante della reazione di dolore. La sua funzione sembra essere quella di recuperare la persona persa pur sapendo che il tentativo è vano; condizione necessaria al fine di accettare il proprio fallimento, assumere l’irrimediabilità della perdita e dunque, attraversare un decorso normale del lutto.
Nel lutto patologico il soggetto non esprime l’impulso a recuperare la persona persa e la collera per essere stato abbandonato; reprime tali espressioni che, però, continuano a vivere all’interno dell’individuo, influenzando in modo distorto sia le sue sensazioni che il suo comportamento.
Nell’infanzia e nel lutto patologico i processi difensivi appaiono accelerati e gli impulsi a recuperare la persona amata perduta possono persistere, dando origine anche a gravi conseguenze.
Freud (1938) sosteneva che in seguito ad una perdita, oltre alla repressione, può attuarsi la dissociazione dell’Io: la parte nascosta, ma conscia della personalità, nega la perdita e sostiene il suo ritorno; allo stesso tempo, un’altra parte condivide all’esterno l’irrimediabilità della perdita.
Bowlby attraverso l’analisi di ricerche che mirano a descrivere la reazione tipica alla perdita di un coniuge nel primo anno successivo alla sua morte, individua quattro fasi nel decorso del lutto: fase di stordimento, fase dello struggimento, fase di disorganizzazione e disperazione e fase di riorganizzazione.
La fase di stordimento può durare da poche ore a una settimana e può essere interrotta da stati di angoscia o collera anche molto intensi. Ad esempio, in seguito alla notizia della perdita del marito, la vedova può sentirsi incapace di accettare la notizia; non riesce ad accettare la morte e può mostrare una calma innaturale che talvolta, può essere interrotta da sentimenti come la collera o il panico.
Nella fase di ricerca e struggimento per la persona perduta la vedova inizia a rendersi conto dell’irrimediabilità della perdita e manifesta angoscia, dolori e pianto contemporaneamente a irrequietezza ed insonnia.
Il suo pensiero è spesso rivolto al marito e percepisce la sensazione della sua presenza, interpretando rumori o segni come manifestazioni del suo ritorno.
Tali espressioni sono comuni a tutte le vedove e dunque, sostiene Bowlby, costituiscono insieme alla collera, un aspetto normale del dolore e del lutto.
Nel lutto sano la necessità di cercare e recuperare la figura scomparsa tende a diminuire con il tempo; nel decorso del lutto patologico invece, tale ricerca persiste in modo intenso e viene espressa in diverse forme distorte e mascherate.
Il pianto, la collera, l’ingratitudine e la ricerca incessante della figura perduta vanno considerati come aspetti tipici della seconda fase del lutto e tentativi di ritrovare e recuperare la persona persa.
In seguito ad una perdita la persona può desiderare di liberarsi dei ricordi del defunto oscillando tra impulsi incompatibili: voler conservare i ricordi o volersene disfare.
La fase di disorganizzazione, disperazione e riorganizzazione comporta la capacità di riuscire a tollerare il tormento emotivo e la sofferenza che il decorso del lutto porta con sé, ammettere il carattere definitivo della morte ed accettare che la propria vita abbia bisogno di una ristrutturazione.
I bambini spesso reagiscono alla perdita negando la sua irrimediabilità e continuano ad aspettarsi il ritorno del genitore.
Secondo Bowlby di fronte ad un lutto sia gli adulti che i bambini necessitano di una persona di fiducia con la quale possano gradualmente stabilire un legame e dunque, accettare definitivamente la perdita e riorganizzare il proprio mondo interno.
Il terapeuta di una persona colpita da una perdita deve prendere in considerazione le sue speranze, i suoi desideri, i suoi rimpianti e i rimproveri che l’affliggono, rispettando le sue sensazioni, seppur illusorie, senza necessariamente intervenire a favore della realtà. Nonostante sia un percorso lungo e difficile, il paziente deve avere la possibilità di esprimere la rabbia per l’abbandono, la collera e la paura della solitudine per poter andare avanti.
Nel lutto patologico le reazioni emotive possono essere violente e prolungate nel tempo; il dolore sembra essere assente mentre il rancore e gli autorimproveri appaiono prevalenti. Tali caratteristiche del lutto accompagnate da depressione, angoscia, ipocondria o alcolismo, possono essere definite come lutto cronico.
Il lutto patologico può manifestarsi anche nel suo contrario, ovvero nell’assenza prolungata di lutto cosciente: la vita del soggetto non sembra stravolta dalla perdita; sono spesso individui autosufficienti, indipendenti e sprezzanti dei sentimenti. Appaiono impegnati ed efficienti ma possono presentare insonnia, tensione, irritabilità e sintomi fisici, apparentemente inspiegabili.
In entrambe le forme di lutto patologico la perdita viene considerata come reversibile e può continuare l’impulso a ricercare il defunto, la collera e l’autorimprovero, mentre la tristezza ed il dolore vengono a mancare.
L’assenza di lutto conscio può essere considerata come un’estensione della fase di stordimento, mentre, le fasi del lutto cronico possono essere considerate come estensioni patologiche della fase di struggimento e ricerca e della disorganizzazione e disperazione.
Il lutto patologico può manifestarsi anche attraverso l’euforia: la reazione euforica alla morte può essere l’esito del rifiuto nel credere che la perdita sia realmente avvenuta o, al contrario, nell’assumere che abbia migliorato la condizione di chi è rimasto in vita.
I processi difensivi messi in atto dal soggetto, al fine di mitigare la sofferenza di una perdita, possono trovarsi sia nelle varianti sane che patologiche di un lutto; ciò che li differenzia è la durata, la rigidità o l’influenza totale o parziale sul funzionamento mentale.
Durante il decorso di un lutto patologico può verificarsi, ad esempio, lo spostamento della collera nei confronti di un’altra persona o altre difese come la rimozione, la scissione o la dissociazione.
Gorer (1965) ha introdotto il termine “mummificazione” per descrivere una forma patologica di reazione alla perdita in cui il soggetto rimasto in vita sembra essere convinto del ritorno del defunto e tende a conservare tutti i suoi oggetti personali in modo che possa trovarli al suo rientro. Sul versante opposto invece, alcune persone che evitano il lutto, tendono a disfarsi di tutto ciò che possa ricordargli la persona scomparsa.
Coloro i quali non hanno vissuto coscientemente il lutto possono presentare forti reazioni emotive e forme di depressione; gli elementi scatenanti della crisi possono essere: la ricorrenza dell’anniversario della morte, un’altra perdita, il raggiungimento dell’età in cui è avvenuta la morte, un’eventuale altra perdita avvenuta ad una persona con la quale il soggetto si è identificato.
Bowlby sostiene che tra le reazioni patologiche alla perdita si può verificare la collocazione impropria del defunto: in un animale, un oggetto, un’altra persona o dentro se stessi. Tale collocazione la si trova nel lutto cronico e se persiste e si stabilizza nel tempo può portare ad una mancata elaborazione del lutto.
L’identità della persona venuta a mancare assume una gravità particolare quando viene attribuita ad un bambino dal genitore che ha subito la perdita.
Cain e Cain (1964) sostengono che tali bambini possono essere stati concepiti come repliche di sorelle o fratelli morti.
Gli autori attraverso osservazioni ottenute su bambini provenienti da una clinica psichiatrica, sostengono che le madri presentavano ancora prima della perdita del proprio bambino una personalità patologica; avevano subito un elevato numero di perdite durante la propria infanzia ed avevano investito narcisisticamente sul proprio figlio quando era ancora in vita.
Bowlby ipotizza che alcuni tipi di personalità siano più vulnerabili alla perdita rispetto ad altri.
Nel determinare il decorso del lutto ha un’importanza rilevante: l’identità o il ruolo della persona perduta, le cause della morte, l’età ed il sesso della persona che resta, le circostanze sociali e psicologiche, la personalità del soggetto ed il tipo di organizzazione del suo comportamento di attaccamento.
Freud (1915) evidenzia la presenza di rapporti ansiosi e ambivalenti sin dall’infanzia in persone che hanno successivamente manifestato disturbi depressivi in seguito ad una perdita; sottolinea la presenza di una fissazione all’oggetto d’amore e difficoltà nel tollerare frustrazioni e delusioni.
Bowlby trae dunque, alcune conclusioni: la maggior parte degli individui che reagiscono alla perdita con un lutto patologico, secondo l’autore, presenta un attaccamento insicuro e ansioso, è incline a prendersi cura in modo coatto di altri, mostra un’autosufficienza emotiva precaria e una forte ambivalenza.
In particolare, asserisce che i disturbi di personalità presenti nel lutto patologico sono il risultato di deviazioni nello sviluppo dell’individuo durante la prima infanzia e l’adolescenza. Alcune deviazioni nascono da rapporti e risposte discontinue da parte di figure parentali nei confronti del bambino e possono tradursi in un attaccamento ansioso e insicuro o in una vigorosa autosufficienza (Bowlby J., 1979; Bowlby J., 1983).
Racamier definisce il lutto come un processo psichico fondamentale per la psiche che si svolge nel corso dell’intera vita. È un processo maturativo universale ed originario; inizia con la vita stessa e termina con la morte.
Il lutto avviene gradualmente e può essere considerato come un processo, un affetto o un lavoro.
Secondo l’autore, non si verifica soltanto in seguito alla perdita dell’oggetto completa ma anche dopo un distacco o in seguito alle esigenze della crescita o alle vicissitudini della vita.
L’Io fin dalla prima infanzia si confronta con la necessità di rinunciare al possesso totale dell’oggetto e compie il lutto di un’unione narcisistica assoluta e tramite questa rinuncia fonda le sue stesse origini, opera la scoperta dell’oggetto e del Sé e inventa l’interiorità.
Racamier sostiene che l’attraversamento del lutto originario comporta un cambiamento per la psiche; è un processo in cui nulla resterà come prima e che non smetterà mai di compiersi.
La madre ed il bambino sono immersi fin da subito in una relazione di reciproca seduzione (seduzione narcisistica) che mira ad escludere e neutralizzare le tensioni provenienti sia dall’interno che dall’esterno ed a rifiutare la differenza, quale presupposto della separazione e del desiderio.
Nel bambino e nella madre agiscono delle tensioni che tendono alla rottura dell’unisono simbiotico; nel bambino operano spinte vitali aggressive, il desiderio di scoperta e di crescita, mentre, nella madre le forze sono complementari e ambivalenti. Il bambino volge le spalle alla madre ponendo fine alla relazione di seduzione narcisistica; dovrà quindi, fare il lutto dell’illusione di appartenenza e onnipotenza totale.
Il bambino scopre l’oggetto in quanto tale soltanto dopo averlo perduto; scopre la madre e la desidera. L’oggetto perduto come oggetto assoluto esterno viene interiorizzato e ritrovato come oggetto interno. L’attraversamento del lutto originario è il presupposto principale per ogni possibile crescita; senza un lutto compiuto non vi è autonomia né per il soggetto né per la sua famiglia.
L’ammirazione provata dalla madre nei confronti del bambino che cresce costituirà tutto ciò che gli serve per andare avanti in una serie di altri lutti originari. Il lutto una volta compiuto lascia una cicatrice originaria indispensabile per conferire all’Io la capacità di tollerare i lutti successivi.
L’attraversamento del lutto originario permette di investire sull’oggetto e su se stessi e di acquisire una sufficiente fiducia di base; al contrario, quando l’Io non riesce ad attraversare il lutto originario, prevale la sfiducia di base nei confronti di se stessi, dell’oggetto e del mondo.
Il lavoro del lutto conduce alla riscoperta di un oggetto e alla possibilità di affrontare grandi e piccoli lutti futuri; tuttavia, non porta ad una immunità totale. Il lutto originario è il modello di ogni crisi o cambiamento a venire; nessun lutto potrà essere superato se non successivamente al processo del lutto originario.
Il lutto potrà essere realizzabile se l’investimento sull’oggetto perduto non è stato eccessivamente ambivalente o narcisistico: se l’oggetto è stato odiato, il lutto può trasformarsi in melanconia e l’oggetto viene introiettato ed attaccato dall’interno per essere conservato; l’oggetto narcisistico invece, non può essere perduto in quanto unito
all’oggetto che lo possiede.
Racamier afferma che quando il lutto fallisce sfocia nella depressione; l’Io non riesce sempre a portare avanti il lutto o a formare una depressione e può dare origine a lutti e depressioni espulse.
L’autore parla di “lutto fissato” per indicare un lutto sospeso, un lutto che non fa rumore, si ferma e si fissa subito dopo esser iniziato; le conseguenze sembrano appartenere al registro somatico.
Il “lutto occluso” può essere definito come il contrario del precedente: il tormento della perdita viene inflitta ad altri; i bambini rimpiazzano figli precedentemente deceduti.
Nell’espulsione del lutto intervengono scissione e diniego: l’Io nega di essere in lutto e depresso e si separa dal resto della psiche che non è riuscito a distruggere.
Il diniego “sfigura” ciò che attacca, mentre, la scissione “immobilizza” ciò da cui l’Io si separa: tale lutto dunque, scisso e denegato, sarà anche evacuato e defantasmato.
Il lavoro del lutto sarà quindi, sfigurato, amalgamato, reso irriconoscibile e trasmesso da una persona all’altra; i figli diventano portabagagli e le loro origini appaiono confuse ed interrotte. Secondo Racamier in ogni depressione o lutto fissato, amalgamato o espulso è possibile rintracciare il segreto o l’incesto.
Al fine di evitare il vissuto di un lutto, l’Io può ricorrere alla suicidosi: minacce e tentativi ripetuti di suicidio che hanno la funzione di sfuggire al dolore e al rischio depressivo; il lutto viene così ripudiato ed espulso, in forma sfigurata, attraverso gli agiti.
Nella suicidosi l’attività fantasmatica è siderata, inerte e vacante ed ogni affetto, così come la depressione, è evitato. Il mondo esterno appare estremamente coinvolto, tanto che, non è il paziente a tormentarsi, ma più il suo ambiente, spesso manipolato ed influenzato.
Racamier afferma che ogni stato depressivo è il fallimento di un lutto e dunque, per poter uscire da una depressione è fondamentale passare attraverso il lutto; accompagnandolo, senza soffocarlo. Attraverso il lavoro di psicoterapia sarà possibile permettere alla porta del lutto di aprirsi e liberare la colpa intrisa nel lutto che genera depressioni.
Secondo l’autore soltanto attraverso il lavoro psicoanalitico sarà possibile restituire al soggetto il processo del lutto espulso; tuttavia, questo ritorno può essere rifiutato e dunque, si dovrà restaurare il narcisismo ferito dell’Io screditato dall’oggetto espulso.
L’analista dovrà perdere l’oggetto, fare il lutto narcisistico della guarigione troppo desiderata e permettere così al paziente di crescere, ritrovare un’età e un avvenire (Racamier P.C., 1992).